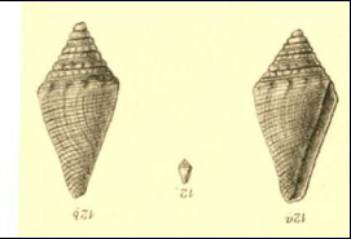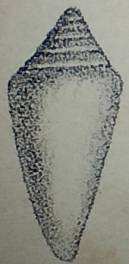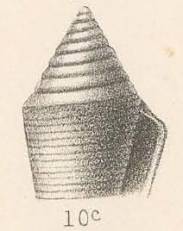Pur
non possedendo esemplari di questa rarissima specie, Vinassa De
Regny non esita ad identificare la specie descritta dal De
Gregorio con il Conus
bimarginatus (Mayer,
1888) (1),
della medesima località.
C'est
une petite jolie espèce dont je regrette de ne posséder qu'un
exemplaire en partie cassé. Malgré le grand nombre des espèces
analogues elle me parait qu'elle diffère des espèces voisines
par des nombreux caractères et qu’on ne puisse pas
l'identifier à aucune d'elles. Parmi les espèces analogues je
dois citer Conus
Defrancei Desh.
(Bassin pl. 100, f. 7-9). C.
incomptus Desh.
(Idem f. 12-13) nodulosus
Desh.
(Idem f. 24-26) lineolatus
Sol.
(Edwards Eoc.Moll. pl. 24, f. 10), concinnus
Sow.
(Idem pl. 24, f. 13) etc. Mais parmi ces espèces celle avec
laquelle il a la plus grande affinité me semble C.
Lamarcki Edw.
(Edwards Eoc. Moll. p. 194, pl. 25, f. 3). Il diffère de celui
ci seulement à cause des sillons qui occupent toute la surface.
Je
n'ai pu sacrifier mon unique spécimen ijour constater si les
cloisons sont réellement résorbées en partie, mais tous les
caractères extérieurs de la coquille sont bien ceux de
Conorbis. Il présente une étroite analogie
de galbe et d'ornementation avec C. emarginata
D'Orb. = C. marginata Grat.
(n. Lk), Grat. Tabl. Dax, n° 330, et Atlas, pl. XX, fig. 46) du
Stampien de Gaas; toutefois sa taille est un peu moindre, la
dépression suturale est moins creuse, les cordons spiraux du
dernier tour sont plus nombreux, plus rapproçhés et beaucoup
moins saillants. C. emarginata est très
vraisemblablement une mutation ancestrale de C. Raulini.
Le genre Conorbis aurait donc survécu jusqu'à
l'Aquitanien.
This
is a pretty little species, of which I regret having only one
partially broken specimen. Despite the large number of similar
species, it seems to me that it differs from neighboring species
in many characters and that it cannot be identified with any of
them. Among the similar species I must mention Conus Defrancei
Desh. (Bassin pl. 100, f. 7-9). C. incomptus Desh. (Idem
f. 12-13) nodulosus Desh. (Idem f. 24-26) lineolatus
Sol. (Edwards Eoc.Moll. pl. 24, f. 10), concinnus Sow.
(Idem pl. 24, f. 13) etc. But
among these species the one with which it has the greatest
affinity seems to me to be C.
Lamarcki Edw.
(Edwards Eoc. Moll. p. 194, pl. 25, f. 3). It differs from this
only because of the furrows which occupy the entire surface.
I
was unable to sacrifice my only specimen to determine whether the
septa are truly partially resorbed, but all the external
characteristics of the shell are indeed those of Conorbis.
It shows a close analogy in shape and ornamentation with C.
emarginata D'Orb. = C. marginata
Grat. (n. Lk), Grat. Tabl. Dax, no. 330, and Atlas, pl. XX, fig.
46) from the Stampian of Gaas; however, its
size is slightly
smaller, the sutural depression is less deep, the spiral cords of
the last whorl are more numerous, closer together, and much less
prominent. C. emarginata is very likely an
ancestral mutation of C. Raulini. The genus
Conorbis would therefore have survived until the
Aquitanian.
Si
tratta di una specie piuttosto piccola, di cui mi rammarico di
avere solo un esemplare parzialmente rotto. Nonostante il gran
numero di specie simili, mi sembra che differisca dalle specie
vicine per molti caratteri e che non possa essere identificata
con nessuna di esse. Tra le specie simili devo menzionare Conus
Defrancei Desh. (Bassin tav. 100, f. 7-9). C. incomptus
Desh. (Idem f. 12-13) nodulosus Desh. (Idem f. 24-26)
lineolatus Sol. (Edwards Eoc.Moll. tav. 24, f. 10),
concinnus Sow. (Idem f. 24, f. 13) ecc. Ma tra queste
specie quella con cui ha la maggiore affinità mi sembra essere
C. Lamarcki
Edw. (Edwards Eoc. Moll. p. 194, tav. 25, f. 3). Si differenzia
da questo solo per i solchi che occupano l'intera superficie.
Non
sono stato in grado di sacrificare il mio unico esemplare per
determinare se i setti siano effettivamente parzialmente
riassorbiti, ma tutte le caratteristiche esterne della conchiglia
sono effettivamente quelle di Conorbis. Mostra una stretta
analogia nella forma e nell'ornamentazione con
C.
emarginata D'Orb. = C. marginata
Grat. (n. Lc), Grat. Tabl. Dax, n. 330, e Atlas, tav. XX, fig.
46) dello Stampiano di Gaas; tuttavia, le sue dimensioni sono
leggermente inferiori, la depressione suturale è meno profonda,
i cordoni spirali dell'ultimo giro sono più numerosi, più
ravvicinati e molto meno prominenti. C. emarginata
è molto probabilmente una mutazione ancestrale di C. Raulini.
Il genere Conorbis sarebbe quindi sopravvissuto fino
all'Aquitaniano.
|
Coquille
de petite taille, assez longue, biconique, couverte de petits
sillons transverses. Spire conique, assez longue, á sommet
pointu. Tours au nombre de neuf environ, étroits, séparés par
une suture linéaire, légèrement canaliculés au milieu,
relevés en bourrelets obtus le long des sutures. Dernier tour du
double plus long que la spire, anguleux en arrière. Ouverture
très étroite, à bords parallèles.
Parmi
les petits Cônes éocènes, c'est, je pense, le C.
Defrance, du
calcaire grossier, auquel mon espèce ressemble le plus. Or, elle
en diffère par son système de sillons transverses et aussi,
paraît-il, par sa spire un peu moins pointue et plus
régulièrement conique(2).
Unicum.
|
|